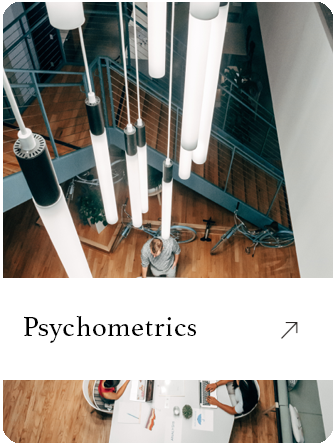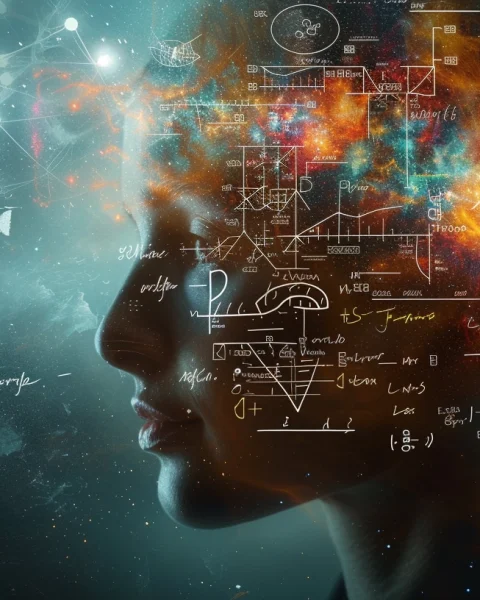Our People
Our Future.
Cosa FacciamoServizi
HR
Sei aree di competenza per un hub unico.
GSO Consulting: sei aree di competenza per un hub unico.
Osserviamo gli scenari dall’alto per elevare il valore del Capitale Umano.
Intercettiamo gli stimoli dal basso per attivare il cambiamento in tempo reale.
Leggiamo i segnali deboli per dare più forza a persone e organizzazioni.
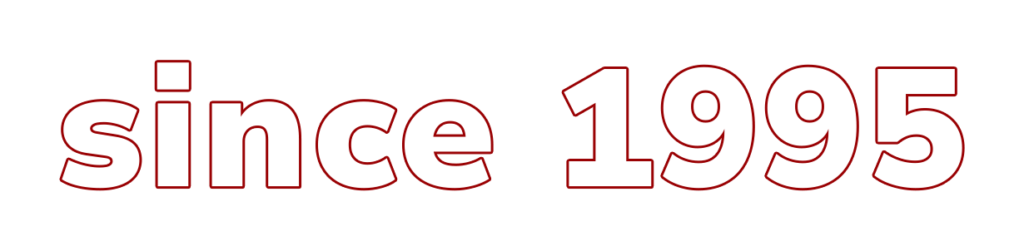
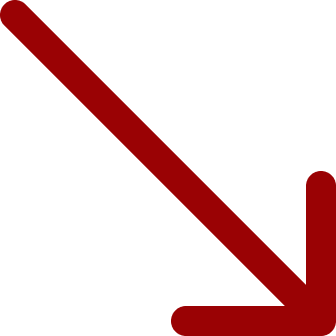
Chi Siamo Siamo una
Società di Consulenza per le Risorse Umane
Offriamo servizi di consulenza per la gestione strategica delle risorse umane, essendo presenti sul mercato dal 1995.
Accompagniamo persone e aziende nei percorsi di sviluppo e
di trasformazione della Vision aziendale in Piani di Azione, valorizzando l’asset più importante: il Capitale Umano.
Con la consapevolezza che solo dalla ricchezza delle diversità possono innescarsi processi di innovazione in grado di generare valore per l’impresa e tutti i suoi stakeholders.
GSO Consulting, oggi, è una holding con sei service lines su diverse aree di offerta, impegnate a fornire alle aziende le soluzioni
più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di business.
Mission La Mission
aziendale di GSO
La nostra Mission è quella di collaborare
con le organizzazioni per facilitare la crescita
del business attraverso soluzioni HR
innovative e personalizzate.
Il nostro obiettivo è diventare un consulente per le risorse umane di fiducia per i nostri clienti, fornendo una guida esperta in materia di reclutamento, gestione delle prestazioni, coinvolgimento dei dipendenti, sviluppo della leadership e cambiamento culturale.
Il nostro team di consulenti esperti si impegna a fornire dei servizi HR di livello superiore, e risultati misurabili in linea con gli obiettivi e i valori dei nostri clienti.
Ci sforziamo di costruire relazioni a lungo termine con i nostri clienti basate su fiducia, onestà e rispetto reciproco.

Valori I Valori
in cui crediamo
Costruire il Futuro
Abbiamo un pensiero chiaro, distintivo e forte del mondo del lavoro del futuro, attorno a cui costruiamo la nostra offerta di prodotto/servizio.
Stupire i Clienti
Diamo il massimo per generare valore per il nostro Business, offrendo una gamma completa di servizi HR che superino le aspettative del Cliente e generino un effetto wow che lasci in loro una sensazione di piacevole meraviglia.
Prendersi cura dell'Ecosistema
Abitiamo luoghi di lavoro piacevoli, ubiqui e smart, fatti da una rete di persone interne ed esterne a GSO, dove ognuno lavora bene con gli altri arricchendosi vicendevolmente delle diversità e partecipando attivamente alla comunità professionale di riferimento.
Lasciare un Segno
Offriamo esperienze memorabili per le menti e i cuori delle persone, sia quelle a cui eroghiamo i nostri prodotti/servizi sia i nostri collaboratori, perché crediamo nello sviluppo e nella sostenibilità.
FAQ Le domande
più frequenti
come valorizzare le risorse umane?
Valorizzare le risorse umane è un passo importante per il successo di qualsiasi azienda. Ci sono molte strategie che puoi adottare per farlo, come ad esempio investire in formazione e sviluppo, creare un ambiente di lavoro positivo e sostenibile, e promuovere la collaborazione e il coinvolgimento dei dipendenti. Inoltre, è importante riconoscere e premiare i dipendenti per il loro lavoro e le loro realizzazioni. Se stai cercando modi per valorizzare le risorse umane nella tua azienda, siamo qui per aiutarti. Scopri i nostri servizi per la gestione delle risorse umane e come possiamo supportare il tuo business.
come valutare le competenze digitali?
Le competenze digitali sono sempre più importanti nel mondo del lavoro di oggi. Valutare le competenze digitali dei dipendenti è un passo cruciale per garantire che la tua azienda sia all’altezza delle sfide del mercato digitale. Ci sono diversi modi per valutare le competenze digitali, come ad esempio attraverso questionari, test online o valutazioni pratiche. È importante considerare le competenze digitali richieste per il ruolo specifico e assicurarsi che i dipendenti siano adeguatamente formati e supportati per sviluppare tali competenze. Se hai bisogno di supporto per valutare le competenze digitali dei tuoi dipendenti, siamo qui per aiutarti. Scopri di più sui nostri servizi di valutazione delle competenze e come possiamo aiutarti a sviluppare un team altamente qualificato.
cosa significa inclusione?
L’inclusione è un concetto importante nel mondo del lavoro e significa creare un ambiente di lavoro equo e rispettoso, dove tutti i dipendenti si sentono accolti, rispettati e valorizzati. L’inclusione significa riconoscere e apprezzare le differenze tra le persone, come il genere, l’etnia, l’orientamento sessuale, la religione e le abilità fisiche e mentali, e promuovere la diversità come un valore fondamentale dell’azienda. Ci sono molte azioni che le aziende possono intraprendere per promuovere l’inclusione, come ad esempio l’adozione di politiche di non discriminazione, l’offerta di programmi di formazione sulla diversità e l’organizzazione di eventi per celebrare le diversità culturali. Se hai bisogno di supporto per promuovere l’inclusione nella tua azienda, siamo qui per aiutarti. Scopri di più sui nostri servizi di consulenza per la diversità e l’inclusione e come possiamo supportare il tuo business.

PartnersCollaborano
con noi
Dove
puoi trovarci